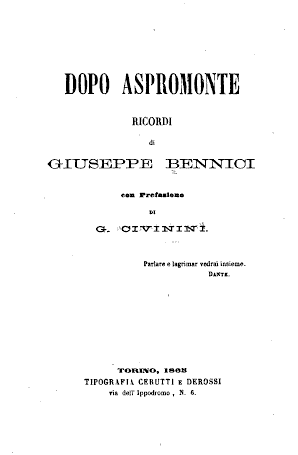Alla domanda posta nel titolo ci si sente di rispondere “martiri” sin d’ora. Le memorie riguardanti la “tragedia” d’Aspromonte, come al tempo fu definita, si connotano, infatti, come ulteriore tassello di quella sistematica trasformazione della parabola garibaldina in una serie di momenti epici ad opera di un apparato propagandistico efficacissimo, interessato a mostrare Garibaldi come esempio vivente di quelle virtù civili che i patrioti risorgimentali cercavano di instillare nel popolo.
Un blog sulle "microstorie" della Basilicata e sulla Storia che ad esse si intreccia.
giovedì 24 settembre 2020
La Calabria. 4. In Aspromonte, martiri o ribelli? L’autorappresentazione in una memoria coeva
Alla domanda posta nel titolo ci si sente di rispondere “martiri” sin d’ora. Le memorie riguardanti la “tragedia” d’Aspromonte, come al tempo fu definita, si connotano, infatti, come ulteriore tassello di quella sistematica trasformazione della parabola garibaldina in una serie di momenti epici ad opera di un apparato propagandistico efficacissimo, interessato a mostrare Garibaldi come esempio vivente di quelle virtù civili che i patrioti risorgimentali cercavano di instillare nel popolo.
giovedì 17 settembre 2020
giovedì 10 settembre 2020
sabato 5 settembre 2020
A margine del libro di Carmine Pinto, ''La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti. 1860-1870"
“Per le plebi meridionali il brigante fu assai spesso il vendicatore e il benefattore: qualche volta fu la giustizia stessa. Le rivolte dei briganti, coscienti o incoscienti, nel maggior numero dei casi ebbero il carattere di vere e selvagge rivolte proletarie. Ciò spiega quello che ad altri e a me è accaduto tante volte di constatare; il popolo delle campagne meridionali non conosce assai spesso nemmeno i nomi dei fondatori dell'unità italiana, ma ricorda con ammirazione i nomi dell'abate Cesare e di Angelo Duca e dei loro più recenti imitatori”. Così si esprimeva Francesco Saverio Nitti a proposito di un fenomeno che, di fatto, molto ha concorso a determinare (sia pure in maniera distorta, fuori fuoco e, negli ultimi anni, aberrante) l’identità meridionale. E da qui dovremmo partire per analizzarne la portata, grazie alle precise e complete informazioni che Carmine Pinto offre in un magnum opus come questa Guerra per il Mezzogiorno, ampiamente documentata e frutto di ricerca capillare. Quando guerra e rivoluzione travolsero ancora una volta il Regno delle Due Sicilie nel 1860, il brigantaggio, infatti, diventò una delle opzioni per la resistenza borbonica al nuovo Stato, costituendosi come una delle espressioni politiche, sociali e criminali della crisi dell’unificazione nel Mezzogiorno, condizionato da eredità e tradizioni di lungo periodo.
La Guerra per il Mezzogiorno si basa su una combinazione ben riuscita di varie chiavi di lettura: una stricto sensu storiografica, una sociologica e, infine, una di tipo politico. Pinto, infatti, vuole ricostruire la dinamica delle forze in campo da angolazioni autonome, il vissuto dei civili e dei combattenti, il ruolo della guerra delle idee e degli interessi. Il libro racconta una guerra dove il ruolo (e il controllo) della popolazione civile fu centrale e prioritaria. Furono coinvolte tutte le province meridionali, ma con gradi e intensità differenti: infatti, le operazioni non coinvolsero mai direttamente le città ed i centri più importanti (tranne che per attività di mobilitazione politica e logistica) e progressivamente si concentrarono nelle fasce appenniniche del Mezzogiorno interno. La guerra contro i briganti, in questo senso, vide emergere per la prima volta una lettura delle province napoletane come una delle aree più problematiche del nuovo stato. Funzionari, militari, intellettuali, politici ne avrebbero costruito narrazioni e rappresentazioni, analisi strutturati o stereotipi destinati a perdurare, individuando tutti nel contesto sociale le principali ragioni del fenomeno, in modo da evidenziare tanto le questioni di congiuntura politica (condannare le antiche istituzioni borboniche), quanto il reale impatto con le province, dove emersero differenze e caratteri che sono stati al centro di studi importanti, anche recenti. Allo stesso tempo il conflitto determinò una prima seria di discussioni, studi, analisi che trasformarono gradualmente la memoria in “mito”. Si tratta, per così dire, a livello di scrittura, di un multitelling, sia sul piano cronologico che tematico, e Pinto cerca proprio di rendere questa simultaneità tenendo insieme le vicende e le prospettive di unitari italiani, borbonici e briganti. Una forma di narrazione funzionale, questa, all’ipotesi di una guerra che fu conseguenza dell’incontro tra la rivoluzione nazionale italiana e l’antico conflitto civile meridionale iniziato alla fine del XVIII secolo.
L’autore utilizza la storia militare, la ricostruzione delle operazioni e le vicende dei combattenti per comprendere le diversificate ragioni che spinsero un’intera società a schierarsi su uno dei due fronti radicalizzando i progetti unitari. Particolare attenzione viene posta a più riprese, come dicevo, sulla guerra ideologica, in quanto entrambi i progetti politici si avvalsero di determinati presupposti progettuali per legittimare e giustificare le proprie azioni. Visuali, queste, utili a confutare una serie di miti che una valanga di pubblicazioni ha contribuito ad alimentare. Quali sono dunque questi miti che l’autore, lasciando parlare i fatti e i documenti, smonta? L’idea che quella del Sud fu una conquista di tipo coloniale da parte del regno sabaudo, di cui tutti i meridionali furono vittime o al più passivi spettatori; l’idea che il Regno delle Due Sicilie fosse un’isola di prosperità e buon governo; l’idea che i briganti, paladini dei popoli oppressi del Sud (oppressi da chi se non dai Borbone stessi e per secoli?), agissero nel pieno del consenso popolare e con un preciso programma sociale, per la spartizione delle terre, e politico, per la libertà, l’uguaglianza e il riscatto degli ultimi.
Carmine Pinto ha affermato, giustamente, che gli storici scrivono per la comunità scientifica e per il pubblico ne che a volte le due cose coincidono. Concordo con lui nel dire che questo volume e il suo successo sia prova della necessità di un maggiore protagonismo della comunità degli storici, di un saper scrivere e divulgare argomenti anche complessi. Non si può parlare di crisi della disciplina a livello nazionale se libri come La Guerra per il Mezzogiorno hanno questo successo e riscontro a tutti i livelli: infatti esso risponde alla grande domanda di storia, visibile in fiction, romanzi, rievocazioni, programmi televisivi, pagine social, eventi pubblici, festival. Questo volume ci mostra che è possibile rafforzare il filo tra storici di professione, studiosi appassionati e grande pubblico e, aggiungo, il compito primario di non raffreddare l’entusiasmo per la storia di qualità può essere svolto in interazione con la scuola, che può insegnare metodi e basi e con le istituzioni, che dovranno investire sulla ricerca di alto profilo.
giovedì 3 settembre 2020
Personaggi. 31. Domenico Corrado
Domenico Corrado era nato a Potenza il 25 novembre 1782 da Francesco e Gerarda Colle, dedicandosi alla carriera militare e conseguendo il gr...